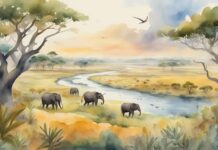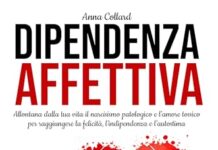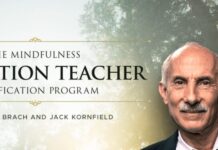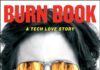Riepilogo: Ricreare fragranze storiche per evocare il passato è un nuovo modo di vivere la cultura nei musei e nei tour.
Fin dai tempi di Aristotele si suppone che esista una gerarchia dei sensi umani.
La vista risulta essere la più importante, poi l’udito, con l’olfatto, il gusto e il tatto più in basso.
Ma se sensi come l’olfatto ricevono meno attenzione nel qui e ora, non ne ricevono quasi nessuna quando si tratta del passato.
Quando pensiamo alla storia culturale – magari visitando un museo o guardando l’arte classica – tendiamo a fare affidamento esclusivamente sui nostri occhi.
Eppure l’olfatto, quando entra in gioco, può essere fortemente evocativo. Quindi forse è giusto che i ricercatori prestino molta più attenzione agli odori del passato.
Fragranze storiche dei secoli passati
Che ne dici di questa domanda, ad esempio: che odore aveva la vita di tutti i giorni 200 anni fa?
La maggior parte degli storici che hanno considerato questo aspetto tendono a pensare che, poiché l’igiene allora non era quella di oggi, l’odore opprimente della vita sarebbe stato l’odore del corpo umano.
La storica dell’arte Dr Érika Wicky non ha mai messo in dubbio questa ipotesi finché, sfogliando i giornali dell’epoca, ha iniziato a notare annunci di vernici inodore.
Ciò le ricordò che le vernici dell’epoca erano solitamente sostanze chimiche estremamente potenti e puzzolenti. La portò a chiedersi come sarebbero stati gli odori dello studio di un artista.
All’epoca, Wicky aveva sede presso il Laboratorio di ricerca storica Rhône-Alpes a Lione, in Francia.
Un giorno sentì parlare di un armadietto per la miscelazione dei colori appartenuto alla pittrice francese Fleury Richard, che lavorò a partire dalla fine del XIX secolo.th secolo.
Armadietto per vernici
Il mobiletto era stato conservato in ottime condizioni nel Museo di Belle Arti di Lione.
Era fornito di più di 100 pigmenti e materiali di altri artisti, ciascuno avvolto in carta, con note apposte di mano del pittore che dicevano cosa fosse ciascuno.
“È un oggetto bello, ma pericoloso”, ha detto il dottor Wicky. “Alcuni pigmenti contengono il 60% di arsenico.”
Ma si rese conto che questo mobiletto sarebbe stato un’ottima fonte per esplorare l’odore che avrebbe avuto lo studio di un pittore.
E così ha iniziato un progetto chiamato PaintOdor, con l’obiettivo di capire quali sarebbero stati gli odori dominanti nello studio di un pittore.
Usando le prove del gabinetto e i materiali scritti dell’epoca, e la conoscenza di altri esperti, il dottor Wicky ha dimostrato che ci sono quattro odori chiave che sarebbero stati aleggianti nell’aria dello studio di un pittore in quel momento.
Si tratta di olio di lino e trementina, che venivano usati per mescolare i colori ad olio; una colla ricavata dalla pelle di coniglio, che veniva utilizzata dipinta sulle tele per renderle più rigide; e vernice, che veniva applicata al dipinto finito per proteggerlo.
Profumieri
Il dottor Wicky ha collaborato con i profumieri dell’azienda svizzera di aromi e fragranze Givaudan per ricreare gli odori di questi materiali (alcuni dei veri prodotti chimici, come la trementina, sono troppo tossici per essere utilizzati).
Il piano è di utilizzarli in una mostra dei dipinti di Richard al museo di Lione l’anno prossimo.
Regaleranno ai visitatori un volantino che li guiderà all’interno di un percorso espositivo dal quale potranno staccare adesivi per annusare gli odori dei materiali degli artisti.
La dottoressa Wicky sta ora finendo di scrivere un libro sul suo progetto. E spera di continuare a studiare il ruolo dell’olfatto nella pittura classica.
Sottolinea che l’olfatto era anche un modo per i pittori di acquisire conoscenza. Spesso controllavano la composizione dei pigmenti, che erano molto costosi, bruciandone piccole quantità e annusandoli, per verificare che i mercanti non stessero cercando di imbrogliarli.
Un secondo filone di ricerca potrebbe ampliare ulteriormente la portata della nostra conoscenza degli odori storici.
ODEUROPA, del valore di 2,8 milioni di euro, è un progetto finanziato dall’UE che mira a sviluppare modalità per catturare la cultura olfattiva storica dell’Europa ed esplorare come istituzioni come i musei possano utilizzare l’olfatto per aumentare l’impatto delle loro collezioni.
“Si tratta del primo progetto di ricerca europeo a sviluppare metodologie informatiche all’avanguardia per catturare e documentare il ruolo che l’olfatto ha svolto – e continua a svolgere – nella nostra cultura,” afferma la prof.ssa Inger Leemans della Royal Academy of Arts and Sciences ( SAPERE) nei Paesi Bassi.
Per cominciare, il team ha esaminato un gran numero di documenti digitali: immagini, dipinti, testi degli anni 17th fino ai primi anni 20th secoli e li etichettarono per evidenziare i riferimenti all’olfatto.
Hanno quindi addestrato un algoritmo di apprendimento automatico a riconoscere questi riferimenti agli odori, quindi hanno impostato l’algoritmo in modo che funzioni su cache di opere d’arte e fonti storiche nei database accademici.
Ciò ha permesso al team di produrre una rete semantica di odori (chiamata European Olfactory Knowledge Graph), che può aiutare i ricercatori a capire come e dove gli odori sono stati creati, sperimentati e compresi.
Il team ha pubblicato diversi documenti che descrivono in dettaglio la loro metodologia. La speranza è che questa rete di conoscenze permetta ai ricercatori di esplorare come gli odori si sono evoluti nel tempo.
Ricerca dell’olfatto
“Stiamo attualmente sviluppando un motore di ricerca che può aiutare gli utenti a scoprire odori correlati, in modo simile a come funzionano i motori di ricerca su Internet,” dice Marieke van Erp, membro del team.
Non ancora disponibile al pubblico, il piano è che una versione sarà sul web nel prossimo futuro.
Un’altra parte importante del progetto consiste nel dare alle istituzioni culturali una maggiore capacità di comunicare al pubblico l’importanza dei profumi.
Nel novembre 2021, il team ha effettuato un tour di prova presso il Museo di Ulm in Germania, dove i visitatori hanno potuto vedere l’arte e annusare gli odori rilevanti del passato mentre procedevano.
Ad esempio, i visitatori hanno visto un dipinto del 1628 di una donna ricca che reggeva un paio di guanti di pelle profumati.
Tali guanti erano un regalo e un accessorio popolare all’epoca. E il team ha lavorato con i profumieri dell’azienda International Flavours and Fragrances per ricreare il profumo in modo che i visitatori potessero annusarlo mentre guardavano il dipinto.
Nel complesso, i visitatori hanno apprezzato molto l’esperienza, afferma George Alexopoulos, un altro membro del team.
“Per molti, usare l’olfatto per pensare a oggetti, storie e luoghi sembra essere interessante ed è qualcosa di nuovo e diverso.”
Profumo dell’inferno
Una parte interessante della ricerca è che le persone reagiscono agli odori in modo diverso. Ci sono certi odori che certe persone, per esempio, non riescono a percepire.
E durante il progetto del Museo di Ulm, il team ha inventato qualcosa che avrebbe dovuto rappresentare l’odore dell’inferno, raffigurato in un dipinto.
Alcuni visitatori lo trovarono chiaramente spiacevole mentre altri lo ritenevano troppo piacevole per adattarsi a un concetto così terrificante da morire.
Il team spera che, in futuro, altri progetti possano attingere ai suoi metodi e strumenti per incorporare ulteriormente il profumo nelle istituzioni culturali.
E per il momento continua a sviluppare tour olfattivi simili.
L’ultimo, chiamato City Sniffers, è un tour a piedi di Amsterdam in cui le persone possono portare con sé un gratta e sniffa in modo da poter sperimentare gli odori rilevanti lungo il percorso.
Ulteriori informazioni
Segui i link sottostanti per saperne di più sui progetti presentati in questo articolo.
Altre notizie scientifiche recenti:
Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Horizon, la rivista europea per la ricerca e l’innovazione.